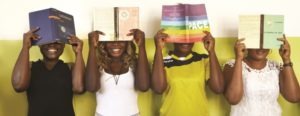Mostar: il ponte (ricostruito) che unisce, le scuole (sotto lo stesso tetto) che dividono
Il percorso a Mostar ti colpisce per l’aspra bellezza, tra montagne coperte di alberi coloratissimi in questi giorni d’autunno (altro che trenino del foliage…) e gole profonde solcate da ruscelli e fiumi.
Nella tavolozza dei verdi e dei bruni si distinguono i molti cimiteri, soprattutto musulmani. L’evidenza di un conflitto dove sono morte tra 100 e 200 mila persone, in larga parte civili, su una popolazione di tre milioni di abitanti, è tangibile. E’ stata una tragedia che ha portato tra l’altro a una seconda diaspora, dopo quella della seconda guerra mondiale. Dopo il ‘95, molti emigranti sono partiti per ragioni economiche o perché riluttanti a tornare in città e villaggi, devastati, non solo materialmente, dalla pulizia etnica. Daniele lungo il tragitto ci ricorda come, ad esempio, Saint Louis, negli Stati Uniti, ha una comunità di 120 mila persone bosniache.
Quando si arriva a Mostar c’è una brezza quasi mediterranea; si capisce che ci stiamo avvicinando all’Adriatico anche da alcune palme svettanti nei giardini delle case.

Qui incontriamo Adi, un cittadino che lavora per l’agenzia turistica contattata dagli organizzatori, con una storia che pare scritta da uno sceneggiatore. Durante la prima parte della guerra, tra il 1992 e l’inizio del 1993, Adi è arruolato con le truppe croato-bosniache per difendere la città dall’attacco dei Serbi svolgendo un ruolo di telefonista. Alla fine del ‘92 ha un permesso turistico per andare in Italia. Dopo poche settimane sarebbe dovuto rientrare in patria ma capisce, da come stanno precipitando gli eventi, che è più prudente non farlo. Tramite un connazionale di etnia serba, che al suo Paese avrebbe considerato acerrimo nemico, in Italia trova prima lavoro in una conceria e poi come operaio edile e parcheggiatore in una discoteca. Facendo doppi lavori, guadagna anche abbastanza bene, più di 2 milioni di lire al mese. Così riesce a mettere da parte un gruzzoletto e a rifarsi una vita in Norvegia. Solo dopo 7 anni, con un viaggio altrettanto rocambolesco, zigzagando mezza Europa tra parenti e amici, torna a Mostar ormai pacificata.
Nel frattempo, dalla metà del ’93, la coalizione croato-musulmana della città, in cui lui aveva militato, si era divisa nelle due componenti e queste avevano iniziato una guerra sanguinosissima. I croati, dalle colline, avevano duramente colpito il quartiere musulmano ed erano riusciti anche a distruggere il simbolo della città, il famoso ponte vecchio, costruito nel XVI secolo dall’architetto ottomano Mimar Hayruddin con grande perizia e ingegno. Il ponte non voleva crollare ma incessantemente, dalle colline, erano stati sparati pezzi di artiglieria fino al colpo fatale del 9 novembre 1993. La ricostruzione iniziò con la fine delle ostilità, grazie ai fondi di Paesi stranieri e terminò nel 2004 dopo circa nove anni di lavori. L’Italia, che donò 6 miliardi delle vecchie lire, ebbe l’onore di vedere il presidente Ciampi invitato dal sindaco di Mostar all’inaugurazione.

Con la sua tagliente ironia balcanica Adi racconta, come in uno sketch, la storia apparentemente assurda di quel periodo: perché tre etnie che vivevano pacificamente fino al giorno prima, camminando nelle stesse strade e mandando i figli a scuola nelle stesse aule, da un momento all’altro si erano accanite le une contro le altre con tale efferatezza?
Qui c’è da introdurre la storia del famoso maresciallo Tito, il “leader maximo” della Jugoslavia per ben 27 anni, un “gran furbo” secondo Adi: aderendo al socialismo internazionale, ma fondando nel contempo il movimento dei Paesi non allineati, riusciva a garantire alla Jugoslavia una certa rendita di posizione. Grazie a lui non si stava affatto male nel Paese, con soldi dalla Russia e rapporti discreti con l’Occidente. Con la sua morte, nel 1980, le cose iniziarono ad andare male e, come per le famiglie le cause dei divorzi sono spesso la perdita del lavoro o il sopraggiungere di gravi disagi finanziari per i coniugi, anche nel caso della Jugoslavia si scatenarono le liti tra le varie repubbliche. Ognuna iniziò a incolpare le altre per la crisi economica galoppante, le religioni diventarono il paravento per nascondere i veri motivi dirompenti e accendere gli animi, sobillandoli contro il nemico esterno. Nel 1989, approfittando della ricorrenza del seicentesimo anniversario, il presidente serbo Milošević raccontò a un comizio molto affollato la storia “eroica” della battaglia della Piana dei Merli, persa dai Serbi contro l’impero ottomano. Fu un discorso di odio esplicitamente indirizzato ad aizzare i nazionalisti serbi contro i musulmani. In estrema sintesi, la retorica di Milošević identificava in quella battaglia persa un punto di svolta da vendicare, per ribadire l’identità del popolo serbo in una sorta di lotta di liberazione contro i discendenti dei “turchi” che, a partire da quell’evento, avrebbero indebitamente occupato il territorio serbo. Fu quello l’inizio della dissoluzione della Jugoslavia. Nell’estate del 1991 le repubbliche più ricche, Slovenia e Croazia, si dichiararono indipendenti innescando l’effetto domino che colpì duramente la Bosnia Erzegovina negli anni successivi.

Girando per la città le immagini della guerra sono ancora tutte ben visibili, così come quelle di una pacificazione solo apparente. Molte case danneggiate o semidistrutte dai bombardamenti sono ancora in piedi come organi morti all’interno del tessuto urbano, con scritte che invitano a tenersi alla larga per il pericolo di crolli. Sul monte Hum, che sovrasta la città dalla parte cattolica, svetta una croce di 33 metri, più o meno issata nel punto in cui i croati tiravano granate per distruggere il ponte vecchio. Anche il campanile della chiesa di San Francesco, ricostruito nella parte croato-cattolica della città, è vistosamente sproporzionato rispetto alle dimensioni della base. Daniele ce lo dice con grande semplicità: il campanile doveva svettare per dare un evidente segnale politico sicché, durante la ricostruzione, fu sopraelevato.
E così siamo qui a constatare, a trent’anni di distanza, una competizione etnica-religiosa con i cattolici che, in barba al percorso ecumenico ed interreligioso avviato dagli ultimi papi, sembrano ancora più nazionalisti dei serbi ortodossi, di molto ridotti in questa parte dell’Erzegovina, e dei bosgnacchi (bosniaci musulmani).
Adi ci fa sorridere, ma di un sorriso amaro, quando ci racconta vari aneddoti dai quali si percepisce chiaramente che il conflitto tra croati e bosniaci, le due etnie largamente preponderanti in questo momento qui a Mostar, continua a covare sotto la cenere e spesso basta l’occasione di una partita di calcio tra HŠK Zrinjski e FK Velež, le due squadre cittadine, per darsele di santa ragione. Ci dice che, in una città di 110 mila abitanti, tutte le istituzioni sono doppie: le università, i teatri, le scuole… “Abbiamo le due scuole sotto lo stesso tetto”, così che ogni bambino possa ascoltare la lezione di storia aggiustata ad hoc secondo la narrazione della sua etnia, per continuare a rimanere nel bozzolo del nazionalismo e a coltivare l’odio verso i suoi concittadini dell’altra etnia. Che cosa assurda odiare una persona perché è musulmana o cattolica, come ci fa ancora capire Adi: “Quando noi eravamo piccoli, dopo anni di amicizia, scoprivamo che il nostro compagno di giochi era di una certa religione nel momento in cui andavamo al funerale di un nonno o di una nonna. Come può essere che, con la guerra, questo dell’appartenenza religiosa diversa sia diventato un elemento così imprescindibile e insopportabile?”
Articolo a cura di Paolo Martella, socio CISV che ha partecipato alla pellegrinaggio verso Srebrenica organizzato a trent’anni dal genocidio. A presto con la terza puntata del suo racconto!